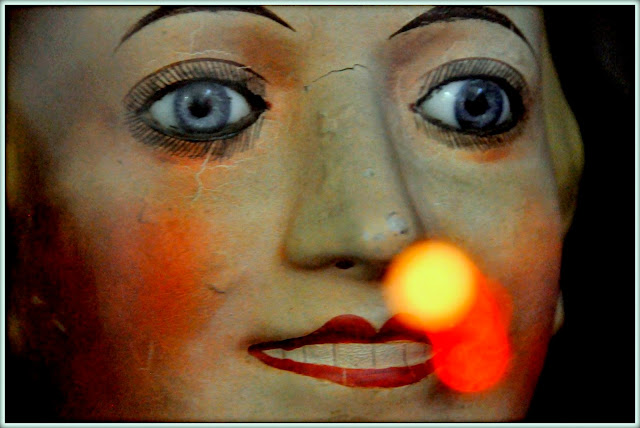| William-Adolphe BOUGUERAU (1825 -1905) - DANTE AND VIRGIL IN HELL (1850) |
E' inutile, io li ho fatti disuguali, impari, dispari, discordi.
Dice con voce pacata, quasi distaccata, impassibile, la figura, poco distinguibile, seduta sul lato destro del grande tavolo nella stanza sconfinata.
L'atmosfera è cristallina, leggera, immobile, candidamente rarefatta.
Sembra l'interno dipinto di certi quadri perfetti, inespressivi, quasi freddi...
Colori distanti, inesplicabili, quasi urticanti nel loro biancore emotivo.
Colori distanti, inesplicabili, quasi urticanti nel loro biancore emotivo.
No, tu menti. Io li ho fatti uguali!
Tutti fratelli, figli dello stesso padre, creature della stessa terra, soggiogati allo stesso destino!
La voce che giunge dall'altro lato del grande tavolo rettangolare, è alterata, il tono rabbioso, il volto severo e duro, lo sguardo affilato, torvo, livoroso.
Un sorriso tagliente scintilla allora sulle labbra serrate e sottili che pronunciano con un filo di fiato le parole più dure.
Io ho messo il bastone nelle mani del fratello, la menzogna nella sua bocca, il desiderio di uccidere nel suo cuore.
Io ho messo il lupo sulla cima del monte, sulla riva del fiume, e l'agnello nella pianura, a bere la bava insanguinata della belva che s'è dissetata del sangue del sacrificio.
Io ho messo il servo nella mani del padrone ed il destino del debole nella disponibilità del prepotente.
Io ho creato il male che conosce tute le armi e le astuzie e con la forza e con con l'inganno schiaccia il bene, ingenuo e flebile.
E tu?
Tu, dimmi, cosa hai saputo fare?
Dimmi, creatore fallito della creatura fallita?
Nell'aria ferma. gli angeli stanno, ora, immobili, ébeti, increduli ad ascoltare le atroci parole della verità che risuonano come colpi di maglio, dardeggiano come vampe del cielo, bruciano come le fiamme dell'inferno.
Non un alito di vita si muove.
I cherubini, muti, si guardano sgomenti.
Le vesti, altrimenti candide, rosseggiano di sanguigni riflessi mentre il cielo sanguina.
Il sole muore, come ogni giorno.
Le nubi avanzano come una tetra cavalleria alla conquista dell'infinito.
Una risata sarcastica, ora, si leva, da quel lato del tavolo donde la malvagità si è eletta trionfante bestia dominatrice del mondo.
Poi, piano, il silenzio.
Un muro di silenzio.
Un silenzio misterioso e lancinante.
S'accosta lentamente, timido, incerto.
Poi, quasi senza volere, si sparge per la stanza.
Occupa l'intero spazio circostante.
E' una nebbia densa, spessa, ovattata che assorbe ogni energia sonora di quell'infame creato.
S'impasta all'atmosfera con quel silenzio liquido e asfissiante.
Si lega in una malta compatta e trasparente.
Baluginano, a tratti, le misteriose particelle dell'atmosfera, sospese, in attesa, bisognose d'una vibrazione, d'un suono, d'una voce riprendere ancora, almeno per un poco, movimento e vita.
Per poter cadere e sparire per sempre alla vista, perdute nel buio dell'incoscienza.
L'immensa stanza sembra espandersi nel cielo infinito.
Solo le lontane, quasi, ormai, invisibili pareti, sottolineano l'ambiente in cui si sta svolgendo quella crudele, terribile tribuna.
L'eterna lotta del male contro il bene si dipana con grandi colpi sotto la cintura.
Tradimenti, inganni, menzogne.
Promesse tradite, giuramenti infranti, voti spezzati.
Come fondale d'una scena distante, un candore luminescente si spande da distanze inafferrabili.
Come una marea opalescente s'appropria dell'intero spazio circostante.
Sembrano annegare, le figure ai due lati del tavolo squadrato.
Angoli appuntiti.
Profili affilati.
Respiri sospesi.
Dall'altro lato del tavolo, il bene esita.
Ristà, lungamente.
Sovrappensiero.
Sembra non aver udito l'arringa scagliatagli contro, come un sasso acuminato, dal demonio in persona.
Il bene, vestito dei panni d'un dio distratto, guarda il suo creato.
E le creature che gli squadernano dinanzi.
L'occhio vivido, d'un azzurro acquoreo.
Come cielo, che brilla d'una luce propria.
Non sente il peso delle parole.
Non sente lo spigolo del dardo lanciato da una fionda traditrice che affonda nello zigomo tenero.
Non si piega.
Impassibile, ineffabile, inerme, insensibile.
Insofferente, il creato freme nella pausa in cui è restato imprigionato.
Ma non può liberarsi, perchè le catene del male sono strettamente legate e le carni già sanguinano.
Gli occhi piangono lacrime calde.
I morti ristanno, immobili, nell'eterno che li consuma.
Il mare li mangia.
Il mare della vita che accorre, affamato e insaziabile.
Stanno lì, i corpi, cadaveri in attesa d'un avvoltoio che presto li divori...
Ma l'attesa s'è impadronita del palcoscenico, facendo bella mostra di sè.
Vestita d'un tutù rosa mostra il suo corpicino vezzoso.
Agile, danza in punta di piedi.
Leggera.
Silfide siderea, rifulge opaca.
Poi, quasi ombra, consumata da un raggio invisibile, si disfa.
Sgrana.
Decade e si deposita come sottile cenere spenta.
Sabbia impalpabile.
Polvere del tempo, infine, s'invola al soffio d'una bocca che, alitando l'eterno, s'apre cercando di dire il bene del mondo.
Lo sguardo del dio del bene s'aggira scrupoloso sul creato che si dipana ai suoi piedi.
Ad una ad una conta le sue pecore, il pastore.
Le accarezza con pio amore paterno.
Con le dita sfiora il soffice vello.
Sollevato, constàta che nessuna creatura manca all'appello.
Tutte si volgono a quello.
Restituendo lo sguardo all'amorevole padre affettuoso.
Fiduciose, porgono il collo alla lama che sta per cadere.
La voce del dio si fa soffio.
Vento.
Tempesta.
Il bene non ha voce, parole, ragione, fede, credenza.
Si fa pioggia.
Grandine.
Dilagante uragano.
Scuote le chiome degli alberi.
Spezza i rami più verdi.
Strappa le più giovani foglie.
Il bene è muto.
Soffia sul mondo in silenzio.
Si rifugia nei teneri cuori.
Si fa ferita.
Lacrima.
Ansioso sospiro.
Immortale, involontaria, speranza.
Apparizione e scomparsa.
Vita.
Morte.
Rinascita.
Qualcosa è accaduto, attorno al lungo tavolo angoluto.
Il demonio è sgomento.
Il riso amaro di scherno s'è fatta dura maschera nera.
La verità incontrastata del suo dire non è stata, infin, contraddetta.
Eppur la vittoria non ha un passo spedito, zoppica, incespica.
Il silenzio s'è fatto, ora, due volte pesante.
I due contendenti soccombono sotto quel gravame pesante.
Alla porta bussa, dura, una mano.
Chiede il conto, la vita.
Vuol esser pagata.
E quelli, invece, han perso moneta.
Ora son vuote le sedie, distanti, ai lati lontani del grande tavolo ossuto.
Il tempo ha roso i due contendenti disfatti.
Son rimasti due scheletri scarni.
Due rami d'albero secco.
Eran due dei.
Due figli dell'uomo.
Fratelli.
Figli dell'unico padre.
Il male ed il bene.